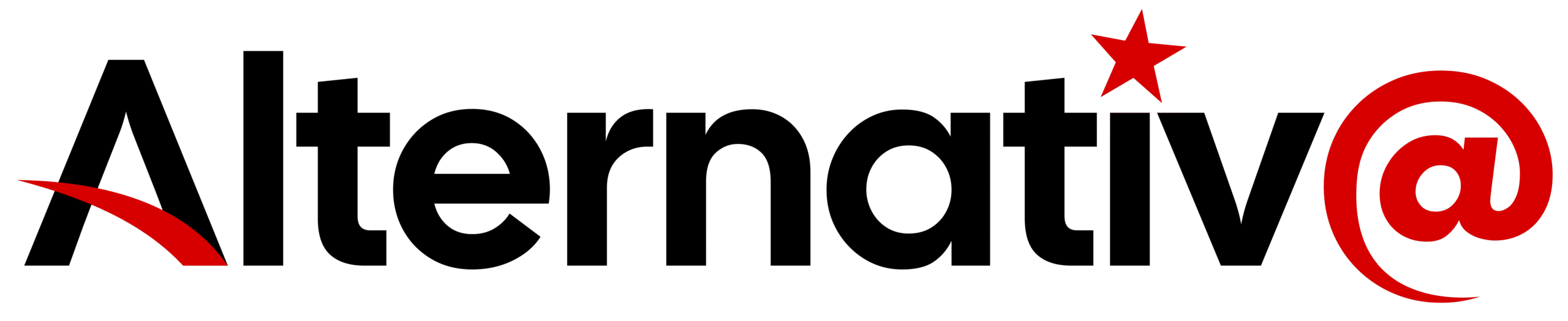«Alcune periferie romane fanno schifo, hanno una bruttezza inaudita».
Così si è espresso il sindaco di Roma Roberto Gualtieri lo scorso 18 luglio, intervenendo agli Stati generali della Bellezza a Cava de’ Tirreni. Il tono ha suscitato un’ondata di polemiche. I partiti di destra hanno colto l’occasione per accusarlo di scarso rispetto verso i quartieri popolari, mentre l’assessore capitolino alle Periferie ha difeso la frase come una provocazione utile ad aprire un dibattito. Ma al di là del clamore mediatico, le parole del sindaco sollevano una questione reale – e pericolosa – su come si pensa e si racconta la città.
Gualtieri ha rivendicato l’intenzione di portare “bellezza ovunque”, immaginando marciapiedi curati, parchi pubblici, spazi accoglienti al posto dei grandi palazzoni. Ma se la “bruttezza” diventa una categoria politica, allora bisogna chiedersi: cosa rende brutta una periferia? L’estetica o l’assenza di servizi, di trasporto pubblico efficiente, di scuole, biblioteche, spazi collettivi, luoghi di socialità e di cultura?
Le periferie romane sono spesso figlie della speculazione edilizia, cresciute senza pianificazione sociale, svuotate da decenni di tagli, privatizzazioni, abbandoni istituzionali. A Tor Bella Monaca o a Corviale, il cemento non è il problema principale: lo è l’assenza di investimenti strutturali, lo è la solitudine, l’isolamento urbanistico, sociale e culturale.
Parlare di “bruttezza inaudita” può apparire onesto, ma è anche ambiguo. Se il problema si riduce all’impatto visivo di un quartiere, si finisce per legittimare interventi dall’alto, processi di gentrificazione, sgomberi, “riqualificazioni” che cancellano il tessuto popolare invece di rafforzarlo. Il rischio è che la retorica della bellezza diventi un filtro ideologico che separa il “centro” dalla “periferia”, chi merita e chi no.
Roma ha attivato 249 cantieri con fondi del PNRR, di cui 110 nelle periferie. C’è un Ufficio per la Qualità Urbana, ci sono progetti di riqualificazione e mobilità sostenibile. Bene. Ma servono di più: politiche strutturali, partecipazione reale delle comunità locali, trasparenza su fondi e cronoprogrammi, spazi pubblici accessibili e liberati da logiche di mercato. Serve pensare la bellezza non come decoro, ma come giustizia urbana.
Bellezza è una scuola che resta aperta anche il pomeriggio. È una linea di autobus che passa ogni dieci minuti. È una casa popolare senza muffa. È uno sportello di ascolto nei consultori. È un presidio culturale autogestito che non viene sgomberato. È una panchina dove ci si può sedere senza sentirsi indesiderati.
Noi lo sappiamo: la periferia è bella quando smette di essere periferia. Quando non è più lontana, dimenticata, invisibile. E per farlo non bastano i marciapiedi nuovi. Serve un’altra idea di città, costruita insieme a chi la vive ogni giorno.
Tratto da Visto da qui