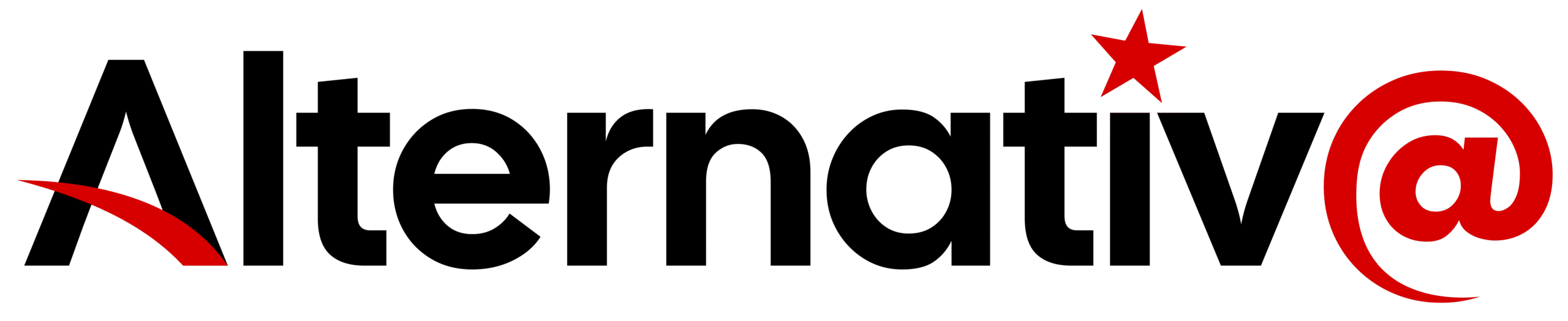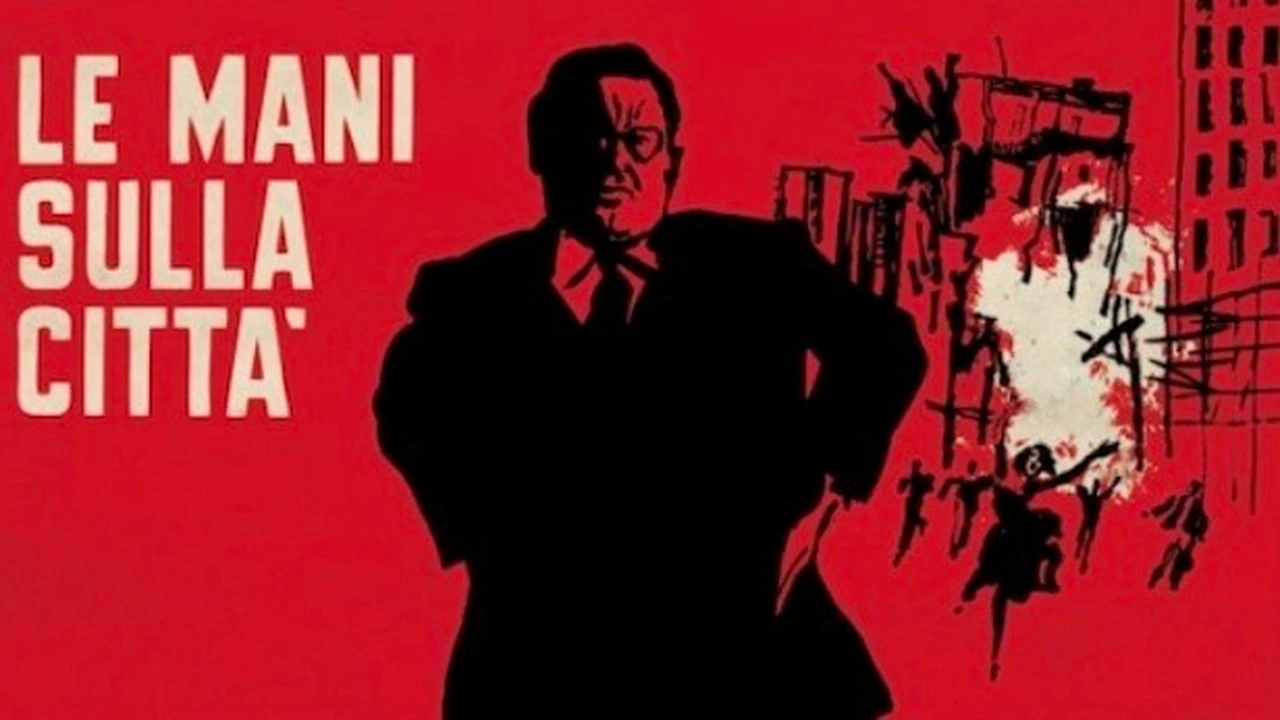Roma è diventata negli ultimi anni un terreno privilegiato per i grandi investimenti immobiliari, con un’accelerazione che ha pochi precedenti. Nel 2024 i capitali professionali diretti sul mercato immobiliare della Capitale hanno raggiunto circa 1,7 miliardi di euro, il doppio rispetto all’anno precedente, portando Roma a rappresentare il 17% del totale nazionale¹. Una crescita alimentata da prezzi ancora inferiori a Milano, dalla spinta dei cantieri legati al Giubileo e da procedure urbanistiche rese più rapide grazie alla digitalizzazione. Ma dietro questa narrazione di modernizzazione e rigenerazione, si intravede con chiarezza una trasformazione che consegna pezzi di città ai fondi immobiliari, con il sostegno politico dell’amministrazione capitolina.
Emblematico è il caso dell’ex Fiera di Roma, nel Municipio VIII, dove il 31 luglio 2025 il Comune ha comunicato l’avvio dei lavori di bonifica e cantierizzazione. L’intervento, sostenuto dal fondo Orchidea, vale oltre 250 milioni di euro e punta a trasformare l’area in un nuovo quartiere con residenze, spazi verdi e servizi². In un contesto di forte domanda abitativa popolare, la quota di edilizia accessibile resta limitata, mentre la valorizzazione immobiliare e i rendimenti futuri per gli investitori sono il vero motore dell’operazione.
Sempre nell’VIII Municipio, l’area AMA alla Montagnola è oggetto di una rigenerazione approvata nel 2025. Qui è prevista la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuove funzioni residenziali e pubbliche su oltre 20.000 metri quadrati, con un investimento stimato attorno ai 100 milioni di euro³. Un’operazione che si presenta come riqualificazione, ma che si inserisce in un processo più ampio di trasformazione urbana dove i capitali privati dettano l’agenda.
Altro caso significativo è Piazza dei Navigatori, sempre nel Municipio VIII, dove i lavori per un complesso residenziale e commerciale comprendono anche la cosiddetta “foresta urbana” progettata dall’architetto Mario Cucinella. L’intervento, promosso dal gruppo Fo.Ro Living, prevede 39.000 metri quadrati di parcheggi e circa 16.000 metri quadrati di verde, presentato come compensazione ambientale⁴. Anche qui la logica è la stessa: edilizia privata di fascia medio-alta, housing sociale residuale e un impatto estetico-ambientale usato come legittimazione di operazioni che restano prima di tutto speculative.
Più a nord, la valorizzazione dell’ex caserma Guido Reni è seguita da CDP Real Asset, con un’offerta presentata nel 2024 dal fondo Coima attraverso il veicolo ESG City Impact, sostenuto da enti previdenziali privati⁵. Un’operazione da centinaia di milioni di euro, che testimonia il ruolo decisivo di fondi nazionali e internazionali nella trasformazione della Capitale.
I dati del mercato confermano il quadro: nel secondo trimestre 2025 i rendimenti lordi medi da locazione residenziale a Roma hanno toccato il 9,8%, mentre i prezzi delle abitazioni hanno segnato una crescita del 3–3,4% su base annua⁶. In parallelo, l’Italia resta attrattiva per i grandi patrimoni internazionali grazie al regime fiscale introdotto con l’articolo 24-bis del TUIR, che consente ai “nuovi residenti” di pagare una tassa forfetaria di 100.000 euro annui sui redditi esteri (25.000 per i familiari aderenti)⁷. Non una misura specifica per Roma, ma che rende più facile la presenza di investitori super-ricchi nei mercati immobiliari delle grandi città.
Il filo conduttore è chiaro: sotto il nome di rigenerazione, si producono operazioni che innalzano i valori immobiliari, favoriscono i rendimenti dei fondi e spingono fuori le fasce di popolazione con redditi medio-bassi. Il compito della politica dovrebbe essere quello di governare questi processi mettendo al centro il diritto alla città e l’equilibrio sociale. A Roma, invece, l’amministrazione Gualtieri ha scelto di accompagnare queste trasformazioni, lasciando che sia la logica della speculazione, e non quella del bene comune, a dettare le priorità urbane.
Tratto da Visto da qui