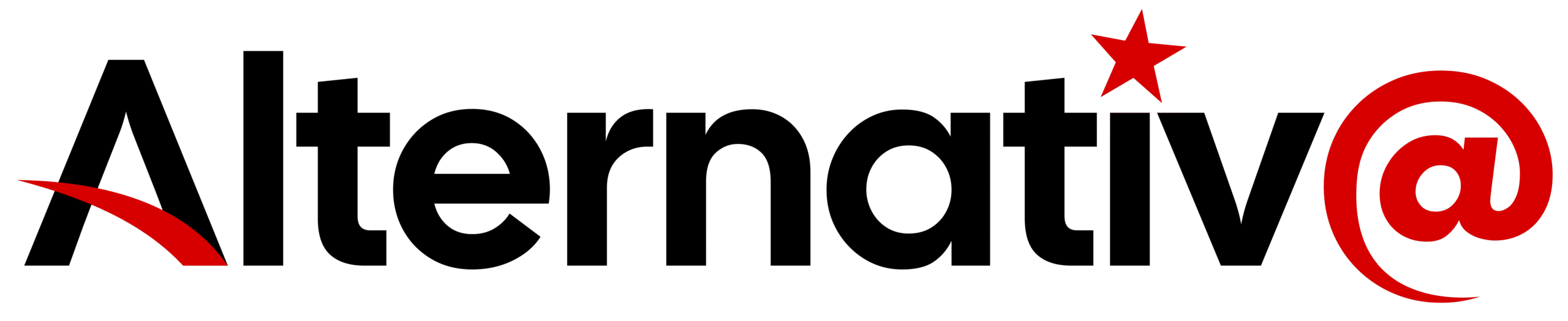Da qualche tempo circola la notizia che una giunta, che si definisce di sinistra, abbia stravolto la città di Milano. In realtà la situazione, da un punto di vista degli effetti urbanistici, non appare molto diversa in molte città, compresa Bergamo. Infatti l’urbanistica basata sui criteri della riqualificazione urbana a Milano come Bergamo ha diversi denominatori comuni: la deregulation, il disinteresse per il bene pubblico e il concentrarsi nel favorire i privati. Certo, a Bergamo non ci sono i palazzi costruiti nei cortili o i grattacieli fatti passare per ristrutturazioni, ma le cose non vanno affatto bene.
Non solo il modello di valorizzazione urbana che si è imposto a Bergamo non ha raggiunto i risultati attesi, ma inizia nella sua crisi a mostrare preoccupanti crepe. Quindi dietro alla cortina fumogena della riqualificazione urbana cosa realmente è avvenuto? Qual è l’idea che aveva sostenuto questo incredibile sviluppo edilizio di Bergamo nell’ultimo decennio?
Partendo dalla tumultuosa crescita dell’aeroporto, ormai diventato il terzo per passeggeri in Italia, è stata immaginata una città in cui i cittadini originari contassero e fossero sempre di meno a vantaggio dell’aumento degli user city. Cioè sugli utenti temporanei degli spazzi urbani. User city che dovevano vedere in Bergamo una meta facilmente raggiungibile a basso costo grazie al low cost. Erano professionisti, turisti e consumatori di eventi (culturali e sportivi), ma anche studenti, lavoratori dell’istruzione, della sanità e dei servizi pubblici. Persone che transitano o risiedono temporaneamente nella città. Non casualmente Bergamo è diventata dal nulla una meta turistica, una città in cui brulicano i B&B a scapito delle famiglie residenti che ormai non trovano più alloggi in affitto. Una città gentrificata in cui il commercio di prossimità sta scomparendo e dove è esploso il fenomeno del street food.
Insomma la gestione dell’urbanistica e dell’edilizia a Bergamo ha portato in primo piano il tema del governo delle trasformazioni urbane. Prima di tutto, si tratta di capire chi ci ha guadagnato, da un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione immobiliare, quali gruppi sociali sono stati coinvolti e quali esclusi.
Va quindi considerato il modello di sviluppo, o meglio di accumulazione, della città e degli squilibri distributivi che ha generato. Si tratta di un modello nel quale l’accumulazione per via fondiaria e immobiliare ha assunto un peso crescente fino a diventare il principale fattore strutturante dell’intera economia urbana (e più precisamente il fattore cui gli altri settori economici devono pagare un contributo crescente). Un modello che vede alcuni gruppi sociali vincenti, altri perdenti, e nel mezzo una sempre più difficile definizione di cosa sia l’interesse pubblico, o meglio collettivo.
Fra i vincenti vi sono sicuramente le nuove élite economiche e finanziarie che si sono riposizionate a presidio di quello che David Harvey definisce come il secondo circuito del capitale, ovvero quello immobiliare, ma anche una parte cospicua di ceti medi e superiori che, in modi diversi, hanno potuto partecipare agli imponenti processi di valorizzazione immobiliare che si sono prodotti in questo decennio. Infatti, il grande capitale organizzato (Percassi, Vitali, ecc.) non è come ovvio l’unico attore di questa fase dell’evoluzione di Bergamo. Pensarlo è errore comune di rappresentazioni manichee di come si sia strutturata questa fase della traiettoria della città. La proprietà diffusa, e in particolare quella di valore elevato concentrata fra i ceti medi e superiori che a Bergamo tradizionalmente si concentrano in città rispetto alla provincia, rappresenta il lato di massa, di questo modello di accumulazione. Quella base di consenso che ha garantito al PD, a trazione liberista, di diventare politicamente egemone con un progetto sociale che potremmo definire di destra economica.
Nulla infatti a che vedere con i valori di giustizia sociale e redistribuzione delle ricchezze tipiche della sinistra, oggi a Bergamo le diseguaglianze sociali si sono allargate a dismisura, e lo sono anche di più se consideriamo la grande Bergamo e la provincia. Ma non si può non considerare il vantaggio economico e simbolico che parte dei ceti medi e superiori urbani hanno tratto da questa fase del capitalismo urbano. Al di là dei vantaggi finanziari, l’immaginario di una città moderna, di fatto tendenzialmente esclusiva, ma simbolicamente attraente perché tecnologicamente avanzata, sostenibile alla micro-scala dell’alloggio o del vicinato, e che assicura una persistente valorizzazione degli investimenti ha avuto e tuttora esercita un forte carica egemonica su un ampio spettro di classi sociali. Ed è questa carica egemonica a rendere sempre complesso disvelare le implicazioni negative di questo modello, anche per i ceti che ne traggono qualche vantaggio finanziario immediato. Per risiedere a Bergamo oggi bisogna essere parte dei ceti superiori oppure dei ceti medi patrimonializzati, ovvero i ceti medi che ereditano un alloggio oppure il capitale per acquistarlo: essere ceto medio dal punto di vista esclusivamente dei redditi o del capitale culturale non è più sufficiente per accedere alla proprietà e alla cittadinanza.
Ma come abbiamo detto la città proprietaria ha bisogno che vi siano popolazioni mobili per la sua stessa riproduzione e valorizzazione. E questa è la fonte principale del latente conflitto sociale fra rigidità del modello proprietario e l’altra dimensione essenziale del capitalismo urbano contemporaneo, ovvero la sua necessità strutturale sia di lavoro cognitivo sia di lavoro nei servizi a basso valore aggiunto. Lavoro che – considerate le sue condizioni di strutturale precarietà e i bassi redditi – tende a vivere invece prevalentemente in affitto. E anche come abbiamo detto, in quota consistente, in forma residenziale non definitiva.
La democrazia locale a Bergamo è quindi sempre più una democrazia proprietaria, che di fatto esclude molti dei suoi abitanti, perché non residenti o irregolari. Significativo in questo senso il dibattito sulla partecipazione con l’abolizione delle circoscrizioni e la creazione delle reti di quartiere, strutture pseudo democratiche ad “usum delfini”,
La base di legittimazione della amministrazione comunale corrisponde, fra forme di esclusione de jure e astensionismo di massa dei ceti popolari, a una frazione minoritaria della città reale. In altre parole: tutti gli abitanti creano valore, solo una parte se ne appropria, e ancora meno decidono come governarne la creazione e distribuzione. Siamo in sostanza a un sistema democratico, ma di tipo oligarchico.
A Bergamo la giunta Bruni (2004-2009) aveva in qualche modo accettato una timida sperimentazione della partecipazione popolare, della difesa degli interessi dei ceti subalterni (PdZ) e ambientali (cintura Verde). È poi seguito il periodo della giunta Tentorio (2009-2014) caratterizzato da politiche conservatrici che tendevano a impedire l’accesso al mercato immobiliare ai grandi gruppi finanziari e esterni alla città, preservando il monopolio di attori immobiliari di vecchio tipo. Quelli che potremmo definire “palazzinari” relativamente localizzati e non molto finanziarizzati. Il famoso “non si tocchi nulla”. Il decennio di Gori (2014-2024) è stato un periodo di reazione all’immobilismo della parte conservatrice da parte della fazione più dinamica e finanziarizzata della classe dirigente. C’è stata una grande accelerazione, ma che dopo un decennio possiamo dirlo con certezza, non ha sortito i risultati attesi, e oggi attraversa le avvisaglie di una crisi annunciata in cui si dibatte la nuova amministrazione.
La mobilitazione contraria al nuovo modello di valorizzazione urbana è stata scarsa, intrisa da compromessi e ambiguità. Non a caso una parte della “sinistra” si è aggregata all’amministrazione e ha alla fine votato ogni scelta imposta dalla fazione vincente della borghesia. La stessa richiesta reiterata di partecipazione, di cui tanto si è discusso, non ha portato a riflettere sulla principale posta in gioco (l’urbanistica, il modello di sviluppo e di accumulazione della città), ma bensì a discutere di oggetti meno rilevanti (la difesa alcuni spazi pubblici o la denuncia delle operazioni più incoerenti). Una opposizione limitata e che si autolimitava, magari nel nome del superamento di orizzonti ritenuti ideologici, e che è risultata priva di orizzonti strategici e in definitiva di prospettive di reale cambiamento e che si è esaurita in inconcludenti battaglie secondarie.
Una certa opposizione più significativa si è avuta da parte di alcuni comitati territoriali. Vi sono state anche forme di opposizione di singoli proprietari, spesso cavalcati dal centrodestra senza molto costrutto elettorale, che hanno visto negli interventi di densificazione edilizia una minaccia per il godimento dei loro diritti di proprietà e della qualità della vita. E certo c’è stata la novità dell’emergere di nuovi attori e mobilitazioni sulla casa che non avevano precedenti recenti. Tuttavia il campo degli attori in campo appare ancora piuttosto limitato.
Quindi, la domanda fondamentale che occorre farsi è quali siano i gruppi sociali e gli interessi di cui, in negativo, si nota l’assenza a Bergamo. E non sono i cittadini, genericamente intesi. Sono soprattutto alcuni gruppi sociali – i nuovi ceti popolari, nella loro varietà e articolazione e con i loro bisogni – i cui livelli di partecipazione al governo urbano sono giunti al punto più basso dal 1945 a oggi. Non è sempre stato così, e non è un destino ineluttabile. Ma per fare in modo che non lo sia serve un lavoro sociale e politico di grande cura e di lungo periodo. E da questa nuova fase che dipende la possibilità che il governo delle città assuma caratteri insorgenti e non quelli tecnocratici. Il tema dell’abitare e del governo dei processi urbani in generale rappresenta un terreno di mobilitazione e partecipazione molto difficile a cui tuttavia va riconosciuto, oggi più che mai, una inevitabile centralità.
* segretario provinciale di Bergamo PRC/SE