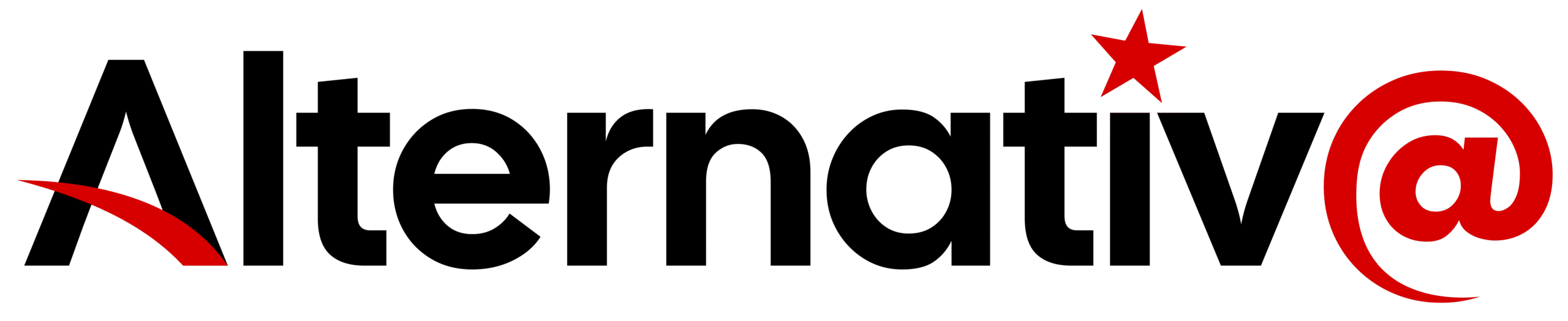Tratto da Lavoro e Salute – di Roberto Romano, economista
Introduzione
In Europa, la crescente percezione del rischio legato all’instabilità geopolitica ha accelerato il dibattito sulla necessità di rafforzare la difesa comune. Nel frattempo, la NATO ha annunciato un aumento degli impegni di spesa militare, sebbene privo di valore giuridicamente vincolante (Gallo D., 2 luglio 2025). Tale dichiarazione si articola in due direttrici principali. La prima prevede che “entro il 2035 almeno il 3,5% del PIL annuo sia destinato, secondo la definizione concordata di spesa per la difesa della NATO, al finanziamento dei requisiti fondamentali della difesa e al raggiungimento degli Obiettivi di Capacità dell’Alleanza”. La seconda stabilisce che “l’1,5% del PIL annuo sia impiegato, tra l’altro, per la protezione delle infrastrutture critiche, la difesa delle reti, la preparazione civile, la resilienza, l’innovazione e il rafforzamento della base industriale della difesa”.
Sebbene l’Unione Europea abbia introdotto la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia nel Patto di Stabilità per consentire maggiori investimenti nel settore, prevedendo l’esclusione dal computo del deficit della spesa militare fino all’1% del PIL, e abbia istituito il fondo SAFE (150 miliardi di euro) che gli Stati membri possono utilizzare e restituire nel tempo, questi strumenti non affrontano i nodi strutturali del progetto. Persistono, infatti, la frammentazione degli interessi nazionali delle industrie militari, la riluttanza degli Stati membri a condividere un debito comune e i vincoli di bilancio che limitano la capacità d’azione pubblica.
Inoltre, anche qualora l’Unione e i singoli Stati decidessero di incrementare la spesa pubblica destinata alla difesa fino al 3,5% del PIL, la clausola europea non sarebbe sufficiente a raggiungere gli obiettivi fissati dalla NATO, considerando che essa resta attivabile solo per quattro anni. Attualmente, la spesa militare dell’area euro a 20 Paesi si attesta all’1,11% del PIL (media 2000-2024), ovvero 2,39 punti percentuali al di sotto del target dell’Alleanza. In altri termini, la clausola europea copre soltanto una parte dell’aumento previsto, rendendo necessario reperire risorse aggiuntive per circa un punto percentuale di PIL. Supponendo una crescita del PIL a prezzi correnti pari al 3,3% annuo nel periodo 2025-2035, in linea con la media del 2000-2024, ciò implicherebbe un crescente impegno finanziario pubblico, anche ipotizzando che la spesa per interessi sul debito resti stabile a poco più di 270 miliardi di euro l’anno per l’area euro a 20, pari all’1,8% del PIL. Tale incidenza è tuttavia più elevata in paesi come l’Italia (4%), la Grecia (3,5%) e la Spagna (2,5%). In ultima analisi, l’aumento della spesa militare europea pone un problema di coerenza politica e democratica. Quanto può spingersi un’Unione che non dispone ancora di un autentico bilancio comune verso la militarizzazione, senza compromettere la propria architettura economica e istituzionale? Esiste una soglia oltre la quale la spesa per la difesa rischia di entrare in conflitto con i principi fondativi della democrazia europea?
Economia e guerra
Ogni guerra è una forma estrema di riorganizzazione della realtà. Quando esplode un conflitto, un Paese non mobilita soltanto le proprie forze armate: mobilita la propria struttura economica, ridefinisce la gerarchia dei bisogni, ricalibra le tecnologie e i flussi produttivi. La guerra rialloca il capitale, ridefinisce le priorità tecnologiche, riconfigura le catene di approvvigionamento e i processi produttivi, accetta il razionamento dei consumi e l’imposizione di nuove tasse, e infine sconvolge gli equilibri del debito pubblico e della moneta, cioè il punto di rottura attraverso cui il sistema capitalistico globale si trasforma. La guerra si combatte nei bilanci, nei mercati energetici, nelle rotte delle materie prime, nelle catene del valore, nei laboratori di ricerca e nelle fabbriche dei microchip.
Carl von Clausewitz definiva la guerra come la continuazione della politica con altri mezzi. Due secoli dopo, è forse più corretto affermare che la guerra è la continuazione della politica economica con mezzi estremi. Ogni grande conflitto moderno è stato, in fondo, una risposta a uno squilibrio economico: alla necessità di ridefinire la distribuzione del valore, delle risorse e delle rendite globali. Ogni decisione di politica economica – un dazio, un sussidio, una politica monetaria – è oggi un atto di posizionamento strategico. Gli Stati non competono più soltanto per il commercio, ma per la capacità di dominio economico: il controllo delle filiere tecnologiche, delle risorse critiche, dei flussi di capitale e della moneta. La guerra, dunque, non si limita a mobilitare risorse: le riorganizza secondo una logica di potenza. Ciò comporta una ridefinizione delle priorità: la competitività non è più misurata solo in termini di produttività o di profitto, ma di autonomia strategica. In un mondo frammentato e instabile, l’indipendenza energetica, alimentare e tecnologica diventa il nuovo indicatore di potenza economica. La “politica economica di guerra” non è più legata alla presenza di un conflitto armato, ma alla percezione costante del rischio. È una condizione permanente di mobilitazione economica e finanziaria, che giustifica la crescita della spesa pubblica, l’espansione del debito e la rinazionalizzazione delle filiere produttive.
La struttura economica che si adegua e cambia
Ogni conflitto produce un proprio modello economico, e viceversa ogni modello economico genera le proprie forme di guerra. La globalizzazione, che per trent’anni aveva unito produzione e consumo su scala planetaria, si frantuma in blocchi regionali. Gli Stati Uniti costruiscono la loro “economia degli alleati”, l’Europa tenta di rafforzare la propria autonomia, la Cina consolida la Belt and Road come sistema parallelo. Il linguaggio è cambiato: non si parla più di libero mercato, ma di friendshoring, reshoring e strategic decoupling: negli Stati Uniti il reshoring ha riguardato il 75% delle aziende entro il 2024, mentre in Europa la percentuale è stata del 65%. Ma dietro questi numeri si nasconde un problema strutturale: il ritorno della produzione in patria richiede ingenti investimenti iniziali per costruire strutture produttive e catene del valore domestiche. Le imprese multinazionali più forti si adattano rapidamente, mentre le economie periferiche, private di accesso ai mercati e alle tecnologie, subiscono le conseguenze della deglobalizzazione sotto forma di inflazione e stagnazione. In questo contesto, il “paradigma dell’economia di guerra” non riguarda soltanto la produzione di armamenti, ma l’intera struttura delle scelte economiche. Ogni decisione di investimento, ogni politica energetica, ogni regolazione tecnologica è oggi motivata da considerazioni strategiche.
Economia di guerra e guerra di economia
Dobbiamo evidenziare due concetti fondamentali: l’economia della guerra e la guerra dell’economia. La prima indica la mobilitazione delle risorse per sostenere un conflitto armato. La seconda, invece, è l’uso di strumenti economici – sanzioni, dazi, blocchi commerciali, congelamento di asset – per condurre un confronto indiretto, capace di redistribuire valore e potere ben oltre il campo di battaglia.” Questa guerra invisibile ha effetti profondi. Le sanzioni rappresentano una strategia di confronto indiretto, utilizzata per influenzare o modificare le politiche o il comportamento di uno Stato senza ricorrere alla forza militare, e riconfigurano gli equilibri geopolitici, con potenziali ripercussioni a lungo termine sulla struttura della politica e del commercio mondiali. La guerra dell’economia, infatti, non mira solo a punire, ma a ridefinire la mappa del valore globale, a riscrivere le gerarchie economiche attraverso il controllo delle reti finanziarie, logistiche e tecnologiche. La sanzione è l’arma perfetta del capitalismo avanzato: agisce sul tempo, non sul territorio. Non distrugge le fabbriche, ma ne interrompe le catene di approvvigionamento. In questo senso, la guerra dell’economia è la forma moderna del blocco navale ottocentesco, ma condotto attraverso infrastrutture digitali, finanziarie e legali. La sua efficacia dipende dal grado di integrazione del sistema: più un’economia è globalizzata, più è vulnerabile.
La nuova geografia economica internazionale
La nuova geografia economica è frammentata, multilivello e conflittuale. Le catene globali del valore non scompaiono, ma si riallineano lungo linee di fiducia politica e affinità strategica. Questa trasformazione non è neutra. È la conseguenza diretta della “guerra dell’economia” e del collasso del vecchio equilibrio commerciale. Questa “regionalizzazione” non è una semplice riorganizzazione logistica: è un processo politico che ridefinisce le alleanze e le dipendenze economiche. Le conseguenze sono molteplici. Da un lato, si creano aree economiche integrate: l’America del Nord intorno agli Stati Uniti, l’Asia intorno alla Cina, e l’Europa nel difficile tentativo di definire un proprio spazio di autonomia. Dall’altro, emergono nuove periferie: regioni che, escluse dalle principali reti di scambio, diventano depositi di risorse ma non di valore aggiunto. Il friendshoring – la riallocazione della produzione in Paesi “amici” – ha una logica difensiva. Mira a ridurre la vulnerabilità, ma comporta una perdita di efficienza e un aumento dei costi. Una guerra commerciale estesa riduce inevitabilmente la crescita economica; i beni prodotti localmente, infatti, non sempre riescono a sostituire rapidamente e adeguatamente quelli stranieri che diventano troppo cari da importare, creando inefficienze, rallentamenti nella produzione e perdita di competitività. Si sta così configurando una nuova divisione internazionale del lavoro, fondata non più sulla produttività, ma sulla fiducia. Le economie avanzate si proteggono; quelle emergenti cercano di inserirsi in catene regionali; quelle più deboli vengono espulse dai circuiti globali. Il ritorno delle tariffe e dei sussidi industriali è solo un sintomo di questo cambiamento. Il principio di fondo è che il mercato non è più considerato neutro: è un campo di battaglia in cui si esercita il potere politico.
Michael Pettis, economista alla Carnegie Endowment, ha descritto questo processo come un cambio di paradigma nella concezione stessa del commercio internazionale. “Le decisioni fiscali, le strutture regolatorie, le politiche del lavoro e le norme istituzionali possono tutte influenzare la distribuzione del reddito e l’equilibrio tra consumo e produzione”, scrive Pettis. Il punto chiave è che gli squilibri commerciali non dipendono solo da ciò che accade “alle frontiere”, ma da come le economie sono strutturate internamente: da come il reddito è distribuito e da quanto le famiglie spendono rispetto a ciò che le imprese producono. In questo senso, la guerra dell’economia è anche una guerra tra modelli sociali.
Le guerre commerciali e valutarie sono, in ultima analisi, conflitti sulla distribuzione del reddito globale. Pettis conclude che per correggere questi squilibri “non basteranno accordi bilaterali o gesti protezionistici. Servirà un cambiamento strutturale: spostare potere e risorse verso coloro la cui spesa sostiene una domanda interna sostenibile.”
La nuova geografia economica internazionale, dunque, non si misura solo in termini di logistica o tecnologia, ma di giustizia economica.
La finanza pubblica può reggere la crescita della spesa militare?
L’economia della guerra – intesa in senso stretto, come mobilitazione di risorse per la difesa – ha un impatto diretto e duraturo sulla finanza pubblica. Ogni euro speso in armamenti è un euro sottratto, almeno nel breve periodo, ad altri impieghi: welfare, infrastrutture, istruzione, sanità. Il ritorno della competizione militare, unito alla transizione energetica e digitale, ha riaperto la questione fondamentale del vincolo fiscale: quanto uno Stato può permettersi di spendere per la sicurezza senza compromettere la sostenibilità del debito? Inoltre, gli studi economici mostrano che, sebbene la produzione militare possa generare occupazione e stimolare settori tecnologici, i suoi effetti moltiplicativi sulla domanda interna sono generalmente inferiori rispetto a quelli di investimenti civili in infrastrutture o servizi, tanto più che l’Europa, che dipende ancora in larga misura dall’industria militare americana, si trova così a finanziare, di fatto, una parte della bilancia commerciale statunitense. Questa dipendenza ha implicazioni strategiche: rende difficile per l’Unione Europea costruire una politica di difesa realmente autonoma. L’aumento del debito pubblico per finanziare la difesa, inoltre, rischia di riaprire la frattura tra Nord e Sud Europa. I Paesi con spazi fiscali limitati saranno costretti a tagliare spese sociali per rispettare i nuovi vincoli di bilancio, accentuando le disuguaglianze interne. Si profila così un nuovo “trade-off fiscale”: tra sicurezza e coesione sociale, tra cannoni e welfare. La domanda, quindi, è se la finanza pubblica possa reggere un’espansione permanente della spesa militare.
“Burro e cannoni”: è ancora valido il dilemma?
Il dilemma tra “burro e cannoni” – tra benessere civile e spesa militare – è antico quanto l’economia moderna. Nella tradizione keynesiana, la spesa militare era considerata uno strumento anticiclico: un modo per sostenere la domanda in tempi di crisi. Oggi, tuttavia, quel dilemma assume una dimensione più profonda. Non si tratta solo di come distribuire il bilancio pubblico, ma di che tipo di società vogliamo costruire.
Il dilemma “burro o cannoni” non è più una scelta binaria, ma una tensione strutturale tra due modelli di accumulazione:
- uno fondato sulla produzione di beni civili e sulla crescita inclusiva,
- l’altro sulla produzione di sicurezza e sulla concentrazione del potere economico.
Il rischio è che la guerra, reale o potenziale, diventi una economia politica della paura, in cui il consenso sociale è costruito non sul benessere, ma sulla minaccia.
Conclusione: il prezzo della guerra, il valore della pace
La guerra dell’economia e l’economia della guerra convergono in un unico sistema globale di potere, in cui la produzione e la finanza diventano strumenti di dominio. Tuttavia, se tutto diventa guerra, anche l’economia perde il suo significato originario: la capacità di garantire la vita e la prosperità delle persone. Il vero “valore della pace” sta nella possibilità di orientare la produzione non alla difesa, ma alla costruzione di un benessere condiviso, di una transizione ecologica, di una nuova giustizia economica.
Ritrovare questa direzione significa ripensare l’economia non come campo di battaglia, ma come spazio politico della cooperazione. La sfida del XXI secolo non è scegliere tra burro e cannoni, ma comprendere che senza burro – senza una base di coesione, equità e fiducia – anche i cannoni non difendono nulla.