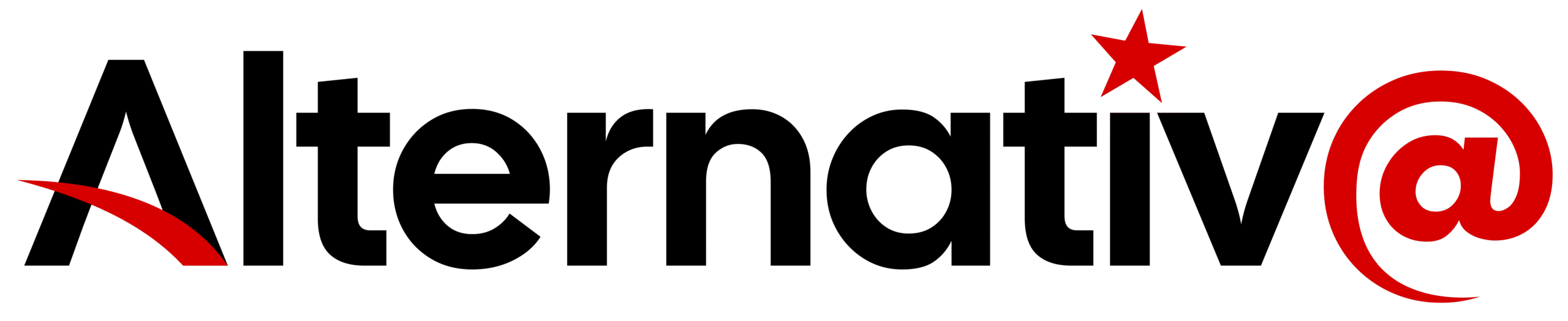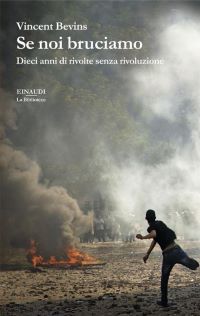Intervista a Vincent Bevins a cura di Filippo Barbera. Bevins è giornalista e scrittore: autore de “Il metodo Giacarta” (Einaudi 2021) e di “Se noi bruciamo” (Einaudi 2024).
Domanda: Nel tuo libro “Se noi bruciamo” racconti il risultato di più di 200 interviste ad attivisti e partecipanti a vari movimenti di protesta che, dal 2010 al 2020, hanno scosso vari Paesi, dalle primavere arabe, all’America meridionale, fino all’Ucraina. Hai, a riguardo, una tesi forte. Qual è?
Bevins: La tesi centrale del libro è che le proteste hanno avuto esiti spesso molto diversi da quelli previsti e che ciò dipende tanto dal repertorio di protesta adottato da questi movimenti, che dalle possibilità materiali e opportunità tecnologiche a loro disposizione. Nelle interviste è emerso un tema ricorrente: tutti mi hanno detto che avrebbero doluto essere molto più organizzati prima che le rivolte invadessero le piazze e le strade. In assenza di organizzazione, infatti, è accaduto che altri gruppi organizzati e capaci di un’azione collettiva hanno approfittato del “vuoto di potere” per riempirlo, prendendosi così il bottino che era stato accumulato. Nel libro sostengo che questa mancanza di organizzazione deriva appunto dal repertorio di protesta di quei movimenti sociali, assorbito dalle proteste svoltesi in Europa e negli Stati Uniti, nel ’68 e negli anni ’70. Un repertorio che si basava sull’orizzontalità, spontaneità, anti-leadership e negazione dell’organizzazione formale della politica.
Domanda: Se i movimenti del 2010 erano basati su questo repertorio pregresso, che ruolo hanno svolto le opportunità materiali e tecnologiche?
Bevins: Alla fine del libro sostengo che c’è stata una sorta di “affinità elettiva” tra alcuni elementi ideologici preesistenti che provenivano in gran parte dalla sinistra antiautoritaria nel “primo mondo” e ciò che era materialmente possibile o più semplice da realizzare date le condizioni del 2010. Così, se si guarda ai vari movimenti che analizzo nel libro, emerge una minoranza di persone impegnate nell’orizzontalismo come filosofia guida e una combinazione di fattori che vanno dall’atomizzazione della società, alla decimazione delle forme classiche di organizzazione, alle nuove tecnologie della comunicazione che hanno reso possibile ed “economico” questo tipo di mobilitazione. Quindi c’è questa “affinità elettiva” tra un repertorio preesistente e ciò che era possibile e conveniente nel 2010.
Domanda: Ci sono, come sempre, anche forze esterne ai contesti nazionali che hanno influenzato questi esiti? O si tratta solo di dinamiche endogene?
Bevins: Sì, assolutamente. Spesso l’importanza del contesto internazionale diventa evidente in un secondo momento della storia. Di frequente è proprio dopo l’inaspettato successo della rivolta iniziale che l’importanza di meccanismi che hanno agito “alle spalle” emerge con maggiore chiarezza. Altre volte, come nel caso Ucraino, invece è evidente fin dall’inizio. Il mio primo libro, Il metodo Jakarta, tratta direttamente della costruzione di un sistema capitalistico globale con gli Stati Uniti come potenza egemone. Ma anche in Se noi bruciamo la relazione con il sistema globale è importante. Dai partiti che si affidano a finanziamenti esterni al ruolo delle ONG, quasi sempre i movimenti sociali di protesta hanno qualche tipo di relazione con le potenze straniere. Molto spesso accade anche che si crei una sorta di “contrattacco” che viene dall’estero in seguito alle proteste. E questa, per esempio, una storia molto comune nel mondo arabo, certamente è anche il caso di Hong Kong dove molti alcuni gruppi hanno avuto finanziamenti dagli Stati Uniti.
Domanda: Vediamo meglio il caso del Cile e quello della Corea del Sud, dove c’è una maggiore continuità tra protesta e cambiamento politico. Perché?
Bevins: Provo a rispondere con un’altra domanda. Perché negli Stati Uniti i leader di “Occupy Wall Street” non sono ora membri del Congresso? Ecco, in Cile e Corea del Sud c’è stata una certa continuità tra società e politica, tra rappresentati e rappresentanti, tra movimenti e istituzioni. Questa continuità può ovviamente prendere diverse forme e seguire molte vie: dalle carriere politiche, alle pressioni delle piazze, allo scambio protesta-consenso, alla capacità di disegnare un’agenda e poi di fare pressioni per attuarla. In ogni caso, ciò segnala la centralità dell’organizzazione politica e la necessità di affrancarsi dall’orizzontalismo, senza per questo riproporre forme gerarchiche di organizzazione.
Gran parte della produzione teorica che ha sostenuto l’approccio orizzontalista ha radici in Italia e la vostra esperienza politica segnala i limiti di questo approccio. Certo l’organizzazione è diventata molto difficile da costruire, ma non impossibile. Se non si affronta questo punto, l’esito delle proteste non può che essere uno solo: i “resti” delle forme organizzative preesistenti sfrutteranno il vuoto di potere per riempirlo come meglio credono. Consideriamo il caso egiziano: gli unici due gruppi che avevano una reale possibilità di sfruttare l’opportunità creata dalla rivolta nel 2011 erano i Fratelli Musulmani e l’esercito. Per un po’ vanno al potere i Fratelli Musulmani, poi si impongono i militari. A fronte di questi esiti, molti dei miei intervistati si sono detti ora convinti che dobbiamo rileggere la teoria rivoluzionaria del XX e del XIX secolo. Non dobbiamo buttare via tutto ciò che è associato, ad esempio, a Lenin o alla politica organizzata. Ancora una volta, la rivolta spontanea della moltitudine, teorizzata e praticata anche nel caso italiano, non ha portato alla trasformazione promessa, anzi. Mi sarebbe piaciuto che così fosse stato, ma non è accaduto. Vale la pena pensarci.