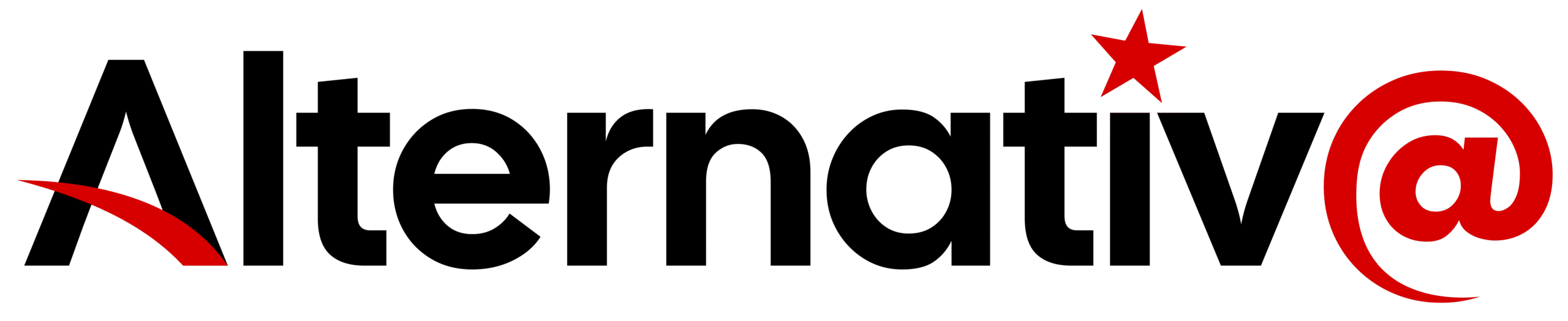di Chiara Pannullo, disegno di Francesco Piobbichi. Pubblichiamo l’interessante riflessione di Chiara Pannullo, attivista del Collettivo Politico 13 Rosso di Firenze, internazionalista, attiva nell’organizzazione delle iniziative culturali dell’Associazione Mariano Ferreyra. (Il titolo è una scelta redazionale)
Nel cuore dell’Africa, dove la cartografia coloniale ha inciso confini come ferite e li ha poi elevati a sistema di governo del mondo, il Sudan non appare più soltanto come un Paese precipitato nella guerra, ma come un laboratorio avanzato del capitalismo tardo-coloniale: l’area di prova in cui si sperimenta ciò che accade quando la sovranità viene sussunta nella logistica e la politica retrocessa a funzione subordinata dell’estrazione. Dall’amministrazione anglo-egiziana che istituì l’economia di piantagione e la gerarchia razziale fra “arabi” e “africani”, ai cicli di aggiustamento strutturale imposti negli anni Ottanta e Novanta che, smantellando proprietà collettive, sussidi e filiere agricole, resero “naturale” la desertificazione sociale, fino al presente, in cui l’intero territorio è ridotto a una sequenza di corridoi, terminali e rendite – la misura della vita non è più politica ma commerciale, e ciò che un tempo si organizzava in società oggi si dispone in logistica.
Se ogni crisi africana viene ridotta nel linguaggio mediatico a “caos”, occorre affermare, con precisione materialista, che quel caos è l’ordine del capitale nella sua forma primitiva e ricorrente: l’uso della forza come tecnologia di pianificazione. Dal 15 aprile 2023, quando le Forze Armate Sudanesi (SAF) di Abdel Fattah al-Burhan e le Rapid Support Forces (RSF) di Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti, hanno aperto un conflitto che la stampa ha chiamato “civile” per non pronunciare la parola “coloniale”, la maschera è caduta. Ciò che si è visto non è la contrapposizione di due visioni del mondo, ma la competizione interna di due frazioni dello stesso blocco di potere che si dividono miniere, dogane, rotte del contrabbando d’oro e di esseri umani: il proiettile, lungi dall’interrompere il mercato, ne diviene l’atto esecutivo, e il valore, non più estratto dal lavoro sotto forma di plusvalore, viene oggi ricavato dalla catastrofe sotto forma di rendita.
Dentro questa economia della distruzione, la filiera è perfettamente trasparente e tuttavia negata: l’oro del Darfur, mescolato alle rovine dei villaggi e alla fuga dei sopravvissuti, viaggia verso il Ciad, viene raffinato a Dubai e reimmesso nei circuiti finanziari che alimentano il ciclo di accumulazione del Golfo; la Russia, attraverso la rete Wagner e le sue reincarnazioni societarie, scambia addestramento, armamenti e copertura logistica per concessioni minerarie e basi sul Mar Rosso; gli Stati Uniti, che denunciano la violenza a parole, proteggono nei fatti l’architettura dei propri alleati regionali; l’Europa, che firma accordi di contenimento migratorio e chiude i porti, rafforza con quei medesimi accordi la riproduzione delle cause della fuga. Il risultato, che si finge “inevitabile”, è il dispositivo perfetto: la devastazione produce rendita e la rendita finanzia nuova devastazione, in un circuito che il linguaggio umanitario addolcisce ma non altera.
Per comprendere la particolarità sudanese non serve indulgere a spiegazioni antropologiche: basta seguire la genealogia militare ed economica delle RSF, discendenti dirette delle janjaweed armate dal regime di Omar al-Bashir durante la guerra del Darfur dei primi anni Duemila. L’ordine coloniale interno – la distinzione burocratica, importata e poi naturalizzata, fra “arabi” islamizzati e popolazioni “africane” stanziali – divenne la griglia di reclutamento per un esercito di riserva capace di bruciare villaggi masalit, fur e zaghawa, svuotare terre e separare i sopravvissuti dai mezzi di sussistenza. Nella fase successiva, questa matrice si privatizza e si aziendalizza: Hemedti, pastore divenuto imprenditore della guerra, costruisce un apparato che è al tempo stesso milizia, conglomerato minerario e holding della logistica – una polizia etnica del capitale che ridisegna i confini non per difenderli ma per monetizzarli, che impiega la violenza come atto di pianificazione territoriale, che retribuisce i combattenti con percentuali sulle esportazioni e che trasforma il massacro in bonifica, l’esodo in infrastruttura, l’umiliazione in segnaletica proprietaria.
A El-Fashir e El-Geneina, dove tra il 2024 e il 2025 interi quartieri sono stati cancellati e le comunità masalit, già colpite negli anni precedenti, hanno subito omicidi, impiccagioni, stupri e saccheggi sistematici, l’orrore non è l’eccesso ma la norma. Lo scopo è rendere impossibile il ritorno, consolidare i corridoi dell’oro, normalizzare la presenza delle RSF come unico soggetto capace di “garantire sicurezza” – una sicurezza che coincide con la stabilità dei flussi. Quando la stampa parla di “tribù”, di “signori della guerra”, di “faide ancestrali”, bisogna ricordare che la “tribù”, in questo contesto, è il nome coloniale dei rapporti economici invisibili: dietro ogni etichetta etnica si muovono bilanci, contratti, margini di profitto e compratori d’oro, mentre l’umanitarismo, con le sue sigle e le sue tende, chiude il circuito trasformando lo sradicamento in “presa in carico” e la politica dell’espulsione in gestione del bisogno.
Allargando lo sguardo oltre il Sudan, la coerenza di questo ordine – insieme imperiale e mercantile – si manifesta con chiarezza. Il Sahel è nominato “fronte contro il terrorismo” per giustificare l’esternalizzazione delle frontiere europee; la Repubblica Democratica del Congo ripete, dagli anni Novanta, la scena del coltan e del cobalto estratti da minatori ridotti a braccia della “transizione verde”; lo Yemen sopravvive come guerra per procura, banco di prova di droni e catastrofi umanitarie; l’Ucraina, volto europeo della stessa logica, diventa il teatro in cui la narrazione occidentale della “difesa dell’egemonia travestita da civiltà” copre la medesima economia della fornitura bellica, della riconversione industriale e della ricostruzione come mercato. Dal Maghreb al Donbass, passando per il Mar Rosso, si rivela come il capitalismo, non potendo più legittimarsi con la promessa di progresso, cerchi ora di legittimarsi con la promessa di ordine – e come tale ordine non sia che l’amministrazione della crisi resa permanente.
Nel dibattito occidentale, parlare del Sudan significa in realtà parlare di sé: del bisogno di rimuovere la propria complicità storica e presente. Così, quando le piazze – dalla fine del 2023 – hanno riportato al centro la questione palestinese come questione coloniale, sono riemerse voci, dalla destra filo-israeliana ai network liberal-atlantisti fino al senso comune giornalistico, che hanno “scoperto” la tragedia sudanese per brandirla come clava contro quelle stesse piazze, sospirando: “Se anche in Sudan, tra popolazioni di lingua e cultura araba, si consumano simili atrocità, con quale coerenza, allora, difendete gli arabi in Palestina?”
Questa formula, apparentemente imparziale, è in realtà un sillogismo marcio: sposta il fuoco dalla struttura ai soggetti, sostituisce le classi con le appartenenze, confonde il colonialismo – che è rapporto di potere e di proprietà – con una nozione psicologica di “cultura”, cancella la filiera dell’oro e delle armi per inscenare la favola del vizio orientale, e soprattutto contrappone dolori che sono connessi nella medesima architettura imperiale. Chi guarda con coscienza di classe sa che le “tribù” sono il nome coloniale delle classi. Dietro ogni clan, un contratto; dietro ogni odio, un giacimento. Le RSF non sono un’anomalia africana: sono la versione armata del neoliberismo. E il silenzio che le circonda non è indifferenza, ma complicità. Il parallelismo tra Gaza e il Sudan è la menzogna più vile di tutte. Non perché i due dolori non possano convivere, ma perché questo paragone nasce per negare, non per capire. È un parallelismo colpevole, costruito con intenzione politica: serve a screditare l’internazionalismo, a spezzare la catena della solidarietà, a ripristinare l’ordine morale dell’Occidente. Chi lo diffonde non difende il Sudan, difende Israele. E difendendo Israele, difende l’Impero.
La verità è che la solidarietà con la Palestina non esclude quella con il Sudan: la contiene. Chi lotta per Gaza lotta già per il Darfur. Perché entrambe le terre vivono sotto la stessa legge non scritta: quella dell’accumulazione per espropriazione. Il muro di Gaza e il deserto del Darfur sono la stessa frontiera del capitale. E chi oppone l’uno all’altro, mente. O peggio: sa la verità e la cancella.
In questi giorni, infatti, una parte del discorso pubblico occidentale – la più fedele all’ideologia liberale e ai centri dell’atlantismo – tenta di usare il Sudan come pretesto per delegittimare la solidarietà palestinese. Si è insinuato che chi manifesta per Gaza resti cieco davanti a Khartoum, e qualcuno, con più sottigliezza retorica, ha perfino osservato che “si fa fatica a comprendere come si possa difendere gli arabi in Palestina e, nello stesso tempo, ignorare ciò che altri arabi stanno infliggendo in Sudan”. È una formula neutra solo in apparenza: sotto la patina di equanimità, riproduce l’antico disprezzo coloniale secondo cui il mondo arabo e africano sarebbe condannato alla violenza e alla barbarie. L’obiettivo non è il Sudan, ma Gaza – non la giustizia, ma la restaurazione della superiorità morale dell’Occidente.
Dietro questa retorica si muove una strategia precisa: dissolvere la coscienza internazionale delle lotte, separare le resistenze, ripristinare la centralità morale dell’Impero. Il Sudan viene evocato solo per cancellarlo, come controcampo utile a ridurre la questione palestinese a un sentimentalismo selettivo. In realtà, il silenzio sul Sudan è il silenzio sull’intero sistema che lo produce – lo stesso che bombarda Gaza, che arma le RSF, che finanzia gli Emirati e che organizza la guerra come funzione dell’economia.
Il mondo che finge di chiedere “dov’è la sinistra per il Sudan?” è lo stesso che tace sui fondi sovrani di Abu Dhabi, sui contratti della Wagner, sugli accordi di sicurezza europei che trasformano le vittime in statistiche migratorie. La loro domanda è una maschera morale che serve a proteggere il potere, non a interrogarlo. Perché chi comprende la Palestina come frontiera del capitale non può non comprendere anche il Sudan. E chi oggi oppone le due cause, non difende nessuna delle due: difende l’ordine che le opprime entrambe. A Gaza, la violenza è coloniale: un esercito che assedia, bombarda, affama. In Sudan, la violenza è economica: milizie che privatizzano la guerra, stati che comprano la distruzione come materia prima. Due forme della stessa logica. La prima reprime la resistenza; la seconda gestisce la miseria. In entrambe, il corpo del subalterno, della forza-lavoro, è il campo di battaglia. E in entrambe, l’Occidente sceglie dove guardare per continuare a non vedersi.
Il colonialismo non è più un progetto geopolitico: è un dispositivo quotidiano che attraversa la finanza, la tecnologia, l’informazione. Il Sudan e la Palestina ne sono due nodi nella stessa rete globale, e smascherarla è il primo atto di una rivoluzione ancora da venire. Chi considera il Sudan un’eccezione non ha compreso la nuova geografia del dominio. È un modello: le sue frontiere traducono in linguaggio territoriale la logica universale di un potere che organizza la vita attraverso la sua distruzione. Il mondo contemporaneo vive in uno spazio in cui pace e guerra sono divenute forme equivalenti di gestione della violenza.
Dal Sahel al Congo, dallo Yemen all’Ucraina, il principio è identico: la guerra non è più la sospensione dell’economia, è la sua forma più redditizia. La NATO e la Wagner, gli Emirati e gli Stati Uniti, i contractors privati e le ONG operano dentro la stessa infrastruttura globale. Ciò che muta è solo la narrazione. Nel Sahel si chiama “lotta al terrorismo”, in Congo “conflitto minerario”, in Yemen “guerra per procura”, in Ucraina “difesa dell’egemonia occidentale elevata a civiltà”. Ma dietro ogni linguaggio si nasconde la stessa verità: l’accumulazione. Il capitalismo ha bisogno di distruggere per continuare a produrre.
Nel Sahel, il deserto è diventato il confine materiale dell’Europa. Là dove l’Unione Europea paga i governi locali per bloccare i migranti, la guerra è funzionale alla logistica: campi, recinzioni, pattugliamenti, deportazioni. Ogni vita fermata entra nel computo dell’efficienza, segnalando la logica di un potere che fa del deserto una forma di governo e della sopravvivenza una variabile da dover gestire. Così l’Africa occidentale non è più colonia, ma periferia integrata nel comando globale, un magazzino umano che regola per conto del capitale i flussi della forza-lavoro mondiale.
Nel Congo, la violenza è ancora più esplicita. Le miniere di coltan e cobalto, indispensabili per l’industria tecnologica mondiale, sono sorvegliate da milizie locali e compagnie straniere. Ogni smartphone, ogni automobile elettrica, ogni batteria che alimenta la transizione verde contiene un frammento di guerra. Il colonialismo non si è ritirato: si è digitalizzato. Ora parla il linguaggio della sostenibilità, ma il sangue è lo stesso.
Nello Yemen, la guerra è divenuta laboratorio di droni e di catastrofi umanitarie, un Paese cancellato dalle mappe e bombardato per anni da una coalizione guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati, con armi fornite dall’Occidente. Ogni bomba che cade su Sana’a rinnova un contratto di fornitura, prolunga la catena di comando tra il capitale e la distruzione. La guerra funziona come nuovo welfare dell’industria bellica: un meccanismo che riorganizza la produzione e l’occupazione su scala globale, generando miseria nelle periferie e accumulazione nei centri del potere economico.
E poi c’è l’Ucraina, il volto europeo dello stesso processo. Non un caso opposto, ma speculare. La guerra in Ucraina è la versione bianca del colonialismo: il fronte dove l’Occidente si reinventa come vittima per poter continuare a essere impero. La sua estetica è diversa, ma la sua logica identica. Dietro la retorica della libertà si muovono i capitali delle stesse multinazionali che finanziano le guerre in Africa e Medio Oriente. Il complesso militare-industriale che arma Kiev è lo stesso che rifornisce Tel Aviv e Riyad. La democrazia serve da copertura all’estrazione: ogni bomba che cade sul Donbass vale un punto in borsa.
L’ordine del capitale ha completato il proprio ciclo storico trasformando la conquista in pianificazione del dominio. Non espande più confini, li interiorizza: colonizza la crisi, organizza i flussi di materie prime, di migranti, di dati e di consenso. Il suo spazio non è unicamente geografico ma logistico, una rete che non sempre ha bisogno di occupare terre, ma tempi – quelli della produzione, della connessione, dell’informazione – esercitando il proprio potere attraverso il controllo del tempo sociale. Ogni guerra è ormai una variazione di tempo, una sincronizzazione forzata dell’ordine mondiale.
Il Sudan, in questa geografia, rappresenta il punto zero del capitale: il luogo in cui la logica del dominio si manifesta nella sua forma più nuda, priva di ogni sovrastruttura ideologica. Dalla spartizione coloniale di fine Ottocento alla costruzione anglo-egiziana dello Stato, dal lavoro forzato nelle piantagioni di cotone alla privatizzazione delle terre comunitarie imposta dal Fondo Monetario negli anni Ottanta, ogni fase della sua storia ha rappresentato un laboratorio del capitale mondiale. Là dove non servono più pretesti, resta soltanto la rendita come forma ultima dell’accumulazione. Eppure questo Paese non è stato sempre e solo vittima, ma anche teatro di una delle più potenti esperienze anticolonialiste del continente.
Nel dopoguerra, il Partito Comunista Sudanese – tra i più forti e radicati dell’Africa – costruì sindacati, scuole, cooperative e organizzò le prime rivolte popolari contro il dominio britannico. L’indipendenza del 1956 fu il frutto di quella mobilitazione, non di una concessione imperiale. Negli anni Sessanta, Gaafar Nimeiry, salito al potere con il colpo di Stato del 1969, si presentò come alleato dei movimenti socialisti arabi: nazionalizzò banche e industrie, avviò riforme agrarie, provò a spezzare la dipendenza dal capitale occidentale.
Ma Nimeiry si trovò dentro la stessa contraddizione storica che attraversò gran parte dei progetti socialisti del Sud globale: l’illusione di poter costruire una sovranità economica autonoma dentro un mercato mondiale già egemonizzato dal capitale finanziario. Le sue nazionalizzazioni suscitarono l’ostilità delle vecchie classi agrarie e dei grandi commercianti urbani, mentre l’Occidente reagiva con la chiusura dei crediti e l’isolamento diplomatico. Quando la crisi petrolifera mutò gli equilibri internazionali e il ciclo dei non allineati si spense, il Sudan – come altri Stati postcoloniali – fu costretto a scegliere tra la bancarotta e la subordinazione. Il suo “dietrofront” più che una conversione ideologica improvvisa, fu il sintomo di una sconfitta strutturale: quella del socialismo nazionale travolto dalla riorganizzazione globale del capitale tra la fine degli anni Settanta e Ottanta
Ed andò esattamente in questo modo: proprio in quegli anni, piegato dal debito e dall’isolamento, Nimeiry abbandonò la redistribuzione, adottò i programmi del Fondo Monetario – privatizzazioni, tagli salariali, smantellamento delle terre collettive – e lasciò spazio all’islam politico sostenuto dalle monarchie del Golfo. Con il golpe di Omar al-Bashir nel 1989, il Paese si trasformò definitivamente in uno Stato-impresa, fondato sull’alleanza tra islam politico e oligarchia militare. Quando nel 2011 il Sud Sudan ottenne la secessione, le risorse petrolifere si spostarono verso sud e la rendita si concentrò nel Darfur e nel traffico dell’oro: fu lì che nacquero le milizie janjaweed, da cui discendono oggi le RSF. La loro violenza non è una deviazione, ma la prosecuzione diretta delle politiche coloniali britanniche e della logica neoliberale imposta dai centri imperiali.
E così il Sudan finisce per offrirci l’immagine finale della civiltà occidentale: un Paese in fiamme sorretto da banche e da contratti, un popolo espulso dal racconto pubblico perché la sua morte è già stata contabilizzata. L’Africa non è un altrove, ma un dentro invisibile: lo spazio su cui l’Occidente scarica la propria colpa e da cui estrae la propria pace.