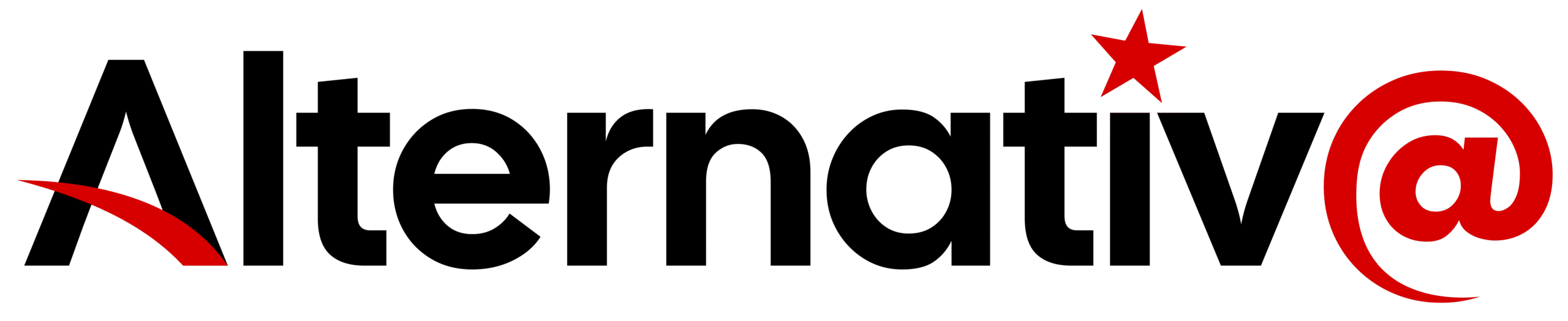Andrea Ciattaglia è funzionario della Fondazione promozione sociale, ente del Terzo settore che opera per la promozione e la tutela dei diritti delle persone malate o con grave disabilità non autosufficienti. È direttore della rivista “Prospettive. I nostri diritti sanitari e sociali” e del notiziario “ControCittà”, foglio informativo delle organizzazioni del Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base di Torino.
Evasia Sancio: Le ultime cifre sugli esclusi dalle cure sanitarie in Italia sono allarmanti. Tra persone che rinunciano alle cure e coloro che, costretti a fruirne, le pagano in proprio sono milioni i residenti italiani per cui il Servizio sanitario nazionale non è più garanzia di cura. Andrea Ciattaglia, della moltitudine degli esclusi, parliamo di quelli che lo sono per cure sanitarie e socio sanitarie di lunga durata, perché non autosufficienti. Cosa significa per loro l’esclusione dalle cure?
Andrea Ciattaglia: Sono i più deboli tra i malati, quelli per i quali stare fuori dalle tutele del Servizio sanitario pesa di più e fa più male alle famiglie, sia in termini economici, sia di carico di cura. In questo campo, l’ingiustizia è dilagante e si manifesta nella forma della violazione del diritto fondamentale alla tutela della salute da parte delle istituzioni. Il livello essenziale delle prestazioni (Lea, Dpcm 12 gennaio 2017, articolo 30) stabilisce per esempio che il ricovero in «lungoassistenza», cioè quello in Residenza sanitaria assistenziale – Rsa, deve essere coperto al 50% dal Servizio sanitario per i malati non autosufficienti. Non sono previste ulteriori restrizioni, che invece tutte le Regioni fissano per limitare la partecipazione pubblica ai ricoveri di lunga durata.
Questo è il vero allarme del settore. Un dato per dare la dimensione del fenomeno: in Piemonte, dove opera principalmente la Fondazione promozione sociale, l’Università Bocconi ha rilevato che oltre il 60% dei malati ricoverati in Rsa paga l’intera retta in proprio. Le famiglie di questi pazienti non autosufficienti hanno fatto richiesta del 50% sanitario all’Asl, che l’ha negato. Sono così costrette ad esborsi che superano i 3mila euro al mese. Stiamo parlando di circa 20mila malati, per una spesa annua di più di 350 milioni di euro di quote sanitarie che oggi vengono corrisposte dai degenti e dai loro cari, anziché dalle Asl.
E.S.: Veniamo da anni in cui si è detto, a livello istituzionale, che «la casa è il primo luogo di cura», qual è la situazione a domicilio per i malati non autosufficienti?
A.C.: Le promesse del Pnrr – quelle raccontate più che quelle scritte nel testo del Piano, che erano assai meno generose – sono state completamente tradite. Il livello delle prestazioni di lunga durata a domicilio è bassissimo e non risponde al fabbisogno degli utenti. Manca del tutto la parte di riconoscimento sanitario delle prestazioni che tecnicamente si chiamano di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare», quelle tipicamente svolte dai parenti o dall’assistente personale, che oggi i Lea escludono dalla sanità e quindi relegano nell’ambito fragilissimo delle politiche sociali e del fondo per la non autosufficienza. Tradotto: i fondi sono limitati e assegnati in base all’Isee del nucleo famigliare molto più che alle condizioni di malattia o grave disabilità della persona non autosufficiente.
È necessaria, invece, una pressione civica sul Parlamento e sul Governo perché l’articolo 22 dei Lea venga modificato prevedendo proprio un riconoscimento delle prestazioni cosiddette “informali”. Si tratterebbe di un esito diverso da quello delle norme – estemporanee e incardinate nel settore delle politiche sociali – relative ai caregiver: il focus sarebbe sempre sul malato/persona con grave disabilità e l’assegno di cura sanitario centrato sui suoi bisogni di tutela della salute a tutto tondo.
E.S.: Sulla non autosufficienza si sono spese da parte del Governo e di molte organizzazioni sociali parole positive e di grande speranza con la riforma scritta nella legge nazionale 33 del 2023, che prometteva di mettere mano al sistema e di garantire servizi dedicati ai non autosufficienti. Oggi anche i promotori parlano apertamente di flop della norma. Cosa è andato storto?
A.C.: Una risposta telegrafica può essere: la legge stessa. La cosiddetta riforma era fin dall’inizio un provvedimento che non conteneva diritti universalistici (destinati a tutti i non autosufficienti, al di là di qualsiasi criterio socio-economico ulteriore) e aveva un esplicito vincolo nelle risorse messe a bilancio. Lo si è visto con la cosiddetta «misura universale», un sostegno a domicilio per i non autosufficienti che ha totalizzato appena 2.000 beneficiari in tutta Italia. Ogni volta che le norme contengono questi vincoli, “comandano” i soldi e non i diritti.
In generale, la norma aveva – e purtroppo ha ancora – la prospettiva di creare un sistema di assistenza separato dal Servizio sanitario per i malati non autosufficienti (il Snaa, Sistema nazionale per la popolazione non autosufficiente). Sarebbero declassati a utenti di serie B, per i quali gli interventi sarebbero determinati non solo, e non tanto, dal bisogno sanitario (nella accezione estensiva che si diceva prima, compresi i bisogni di tutela di salute di lunga durata) ma dalla condizione socio-economica e dalla disponibilità delle risorse messe a sistema. È stato “venduto” come un approccio più tutelante (detto «bio-psico-sociale»), mentre lo sarebbe molto meno, perché vincolerebbe gli interventi sanitari, soprattutto di lunga durata, a condizioni delle persone non autosufficienti e dei loro nuclei familiari che nulla hanno a che vedere con la carenza di salute e con le cure.